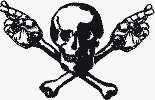Riforma universitaria e mercificazione del sapere
La chiamano riforma Gelmini, ma con la ministra questa legge ha ben poco a che vedere. Sappiamo che fin dal 1997 governi di tutto il mondo si sono riuniti ed hanno cominciato a stilare atti, documenti, convenzioni -formali e non- che decidono sul futuro ed ormai anche sul presente del ruolo dell’università nell’economia moderna. Questo insieme di atti di natura squisitamente di indirizzo politico, oltre i venti ormai, sono molto poco o per nulla pubblicizzati dai media. Essi non hanno la forma di alcun atto giuridico tipico a livello nazionale o sovranazionale (leggi, regolamenti, direttive, trattati). Sono documenti di c.d. “soft law”, non immediatamente vincolanti per i governi firmatari, ma tuttavia dotati di grande forza perentoria. E’ un fatto che nell’ultimo decennio in tutta Europa, ed in tanti altri paesi del mondo, sono state approvate riforme riguardanti il tema dell’istruzione universitaria identiche e spesso sovrapponibili persino nel dettato normativo.
Anche la odierna riforma Gelmini rientra in questo così chiamato Bolonia process, in onore della città in cui venne stilato il più propagandato -ed invero privo dii contenuti- di questi atti di diritto leggero.
Appare pertanto necessario smascherare la mano centrale della riforma che tante mobilitazioni sta suscitando in queste settimane, e comprendere i come ed i perchè si cerchino di forzare così i termini di approvazione in un momento tanto critico per il Berlusconi quater.
Cercando di stilare una non facile elencazione dei tanti punti nodali figli di un progetto unico presenti nel Bolonia process, non si può non iniziare dal costatare che negli ultimi anni praticamente in tutta Europa si è passati repentinamente da un sistema di corsi di laurea a ciclo unico, ad uno a doppio ciclo, improntato perlopiù sul sistema del 3+2 o del 4+1.
La frammentazione fra “grado” e “postgrado”, mascherata da una propaganda di ottimizzazione delle risorse universitarie (ed in Italia abbiamo visto come è finita), rappresenta senza alcun dubbio, e per stessa ammissione del processo cui ci riferiamo, lo strumento più importante per funzionalizzare l’università pubblica alla moderna economia di mercato. In quest’ottica, e chiarendo immediatamente che per logiche di mercato non può intendersi che l’interesse concreto di chi il mercato lo domina (banche e multinazionali) il postgrado sarebbe il momento della specializzazione dello studente, per formarlo al mondo del lavoro che incontrerà di lì a venire. Posto che oggi questo mercato del lavoro sarebbe con forte probabilità una collocazione nel dilagante c.d. settore terziario (servizi), con la sua endemica precarietà, il sapere diventa a questo punto un sapere non neutrale, ma settorializzato. E ciò è tanto più palese per gli indirizzi tecnico-scentifici, mentre quelli umanistici si avviano ad un lento declino per importanza e capacità di costruire un futuro.
Questa prima lettura ci consente già di ipotizzare una sovrapposizione “ideologica” fra riforme del mercato del lavoro (leggi Biagi e Treu) e riforme del sistema universitario.
Aggiungasi ad ogni buon conto che il progetto di rifunzionalizzazione dell’università prevede, ed in certi casi già attua (come in Spagna, Olanda, Belgio, Germania), che il postgrado sia in realtà un master -rigorosamente a pagamento– gestito direttamente da società private.
Per mettere in atto quella che a questo punto possiamo iniziare a delineare come una mercatizzazione del sapere non basta naturalmente modificare i cicli di studio, occorre mettere mano al potere di indirizzo strategico, economico e didattico degli atenei: la governance. Trattasi in altri termini di passare da un sistema pubblico-elettivo ad altro privato-nominativo, annullando il già invero inesistente potere della componente di studenti e ricercatori.
In quest’ottica la lettura della riforma Gelmini è semplice: vengono attribuite le competenza che furono del senato accademico ad un organo emblematicamente chiamato Consiglio di Amministrazione, composto da 11 membri di cui la metà esterni al mondo accademico e con comprovate competenze “organizzative e gestionali”.
Non può qui invero dimenticarsi che già oggi gli organi degli atenei, come quelli della democrazia rappresentativa nazionale e territoriale, erano già indirettamente nelle mani dei privati. Appare tuttavia non meramente simbolica e di scarsa rilevanza un’attribuzione così diretta, la possibilità di sommare al curriculum di un consigliere del cda di una banca il ruolo di consigliere del cda di un ateneo.
Vi è poi la questione in questi mesi tanto dibattuta della ricerca. Occorre in primo luogo collocare la sua funzione dentro il mondo accademico. Giova sfatare un mito costruito dalla propaganda mediatica del governo: il ruolo di ricercatore ha una dignità propria, essendo caratterizzato dal tempo e dalla sperimentazione libera dell’individuo e dalla sua verosimile indifferenza a logiche di carrierismo accademico. Chi è ricercatore può infatti, e questo è il bello, farne un mestiere, avendo la passione protesa all’elaborazione intelletuale e scientifica, non l’ambizione di diventare necessariamente un professore.
Tuttavia al capitalismo moderno importa sempre meno di una ricerca pubblica, libera, non funzionalizzata.
Di qui i nuovi contratti per ricercatori previsti dalla riforma Gelmini, i 3+3, che fanno del soggetto in questione un precario ab origine. Di qui i tagli indiscriminati al fondo pubblico ordinario (e quindi indirettamente alla ricerca) sanciti dalla legge 133/2008 e pedissequamente riconfermati nelle successive leggi finanziarie.
Non è difficile immaginare a questo punto quale sia sentiero designato.
La ricerca universitaria, possibile veicolo di libertà per un popolo, una libertà costruita con l’intelligenza dei suoi individui, diventa viceversa veicolo di asservimento dei saperi al monopolio del capitale moderno. Immaginiamo in quest’ottica il futuro delle facoltà di medicina, biologia, chimica. Saperi già parziali perchè compressi dalla temporalità indotta dal sistema dei crediti saranno inoltre progressivamente vincolati ad produzione di parte, la parte del profitto.
Se è a questo punto chiara la matrice tipicamente capitalista della riforma Gelmini non stupirà il fatto che si cerchi contestualmente di creare un’università per ricchi, di elite. Si innalzano a dismisura i costi di accesso per mezzo dei reiterati tagli al fondo ordinario. Di più, continuano a non inserirsi validi elementi di valutazione del fondo ordinario stesso da parte degli atenei. Si limita l’accesso al welfare per mezzo della c.d. Meritocrazia, ma noi sappiamo benissimo che non esiste merito senza reddito.
Si destinano ad enti privati fondi per le borse di studio.
Tutte queste condiderazioni ci portano ad individuare tutti i caratteri distintivi di quella che possiamo sempre più a ragione definire un’università-fabbrica: non più solo per la compressione degli spazi e dei tempi di vita legati alla tempistica dei corsi obbligatori, degli appelli di esame e della possibile necessità di dover lavorare per potersi mantenere gli studi; ma anche per la palese ispirazione imprenditoriale del modello di governance, per la funzionalizzazione della didattica e della ricerca.
E’ in itinere un percorso occulto di trasformazione del ruolo del sapere dentro la società, un percorso già ben avviato ma lontano dal suo punto di arrivo.
Per questo si ritiene oggi importante trattare i vari aspetti della riforma come un tutt’uno complessivo, per questo è importante collocarli dentro il sistema politico contemporaneo.
Non scopriamo oggi che la mano che dirige la mercificazione del sapere è la stessa che costruisce oggi un sistema di vite precarie, è la stessa che invece di scommettere sulle specificità dei territori li deturpa per costruire i mostri del consumismo.
Sappiamo che è da ipocriti parlare di università e non capire quanto essa sia strettamente legata alla trasformazione del lavoro salariato ed in definitiva ad un’economia del profitto guerrafondaia ed alienante.
Scienze politiche occupata